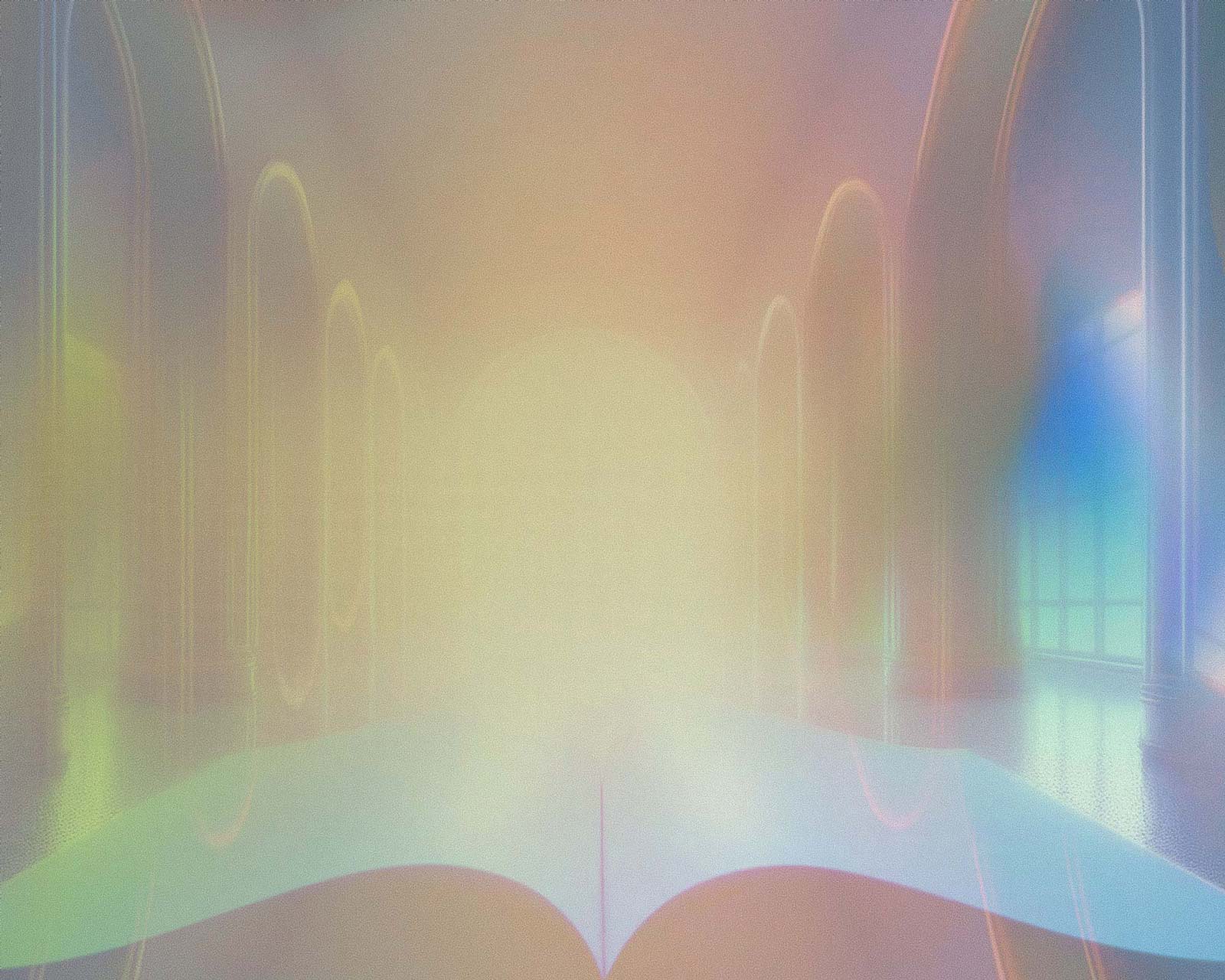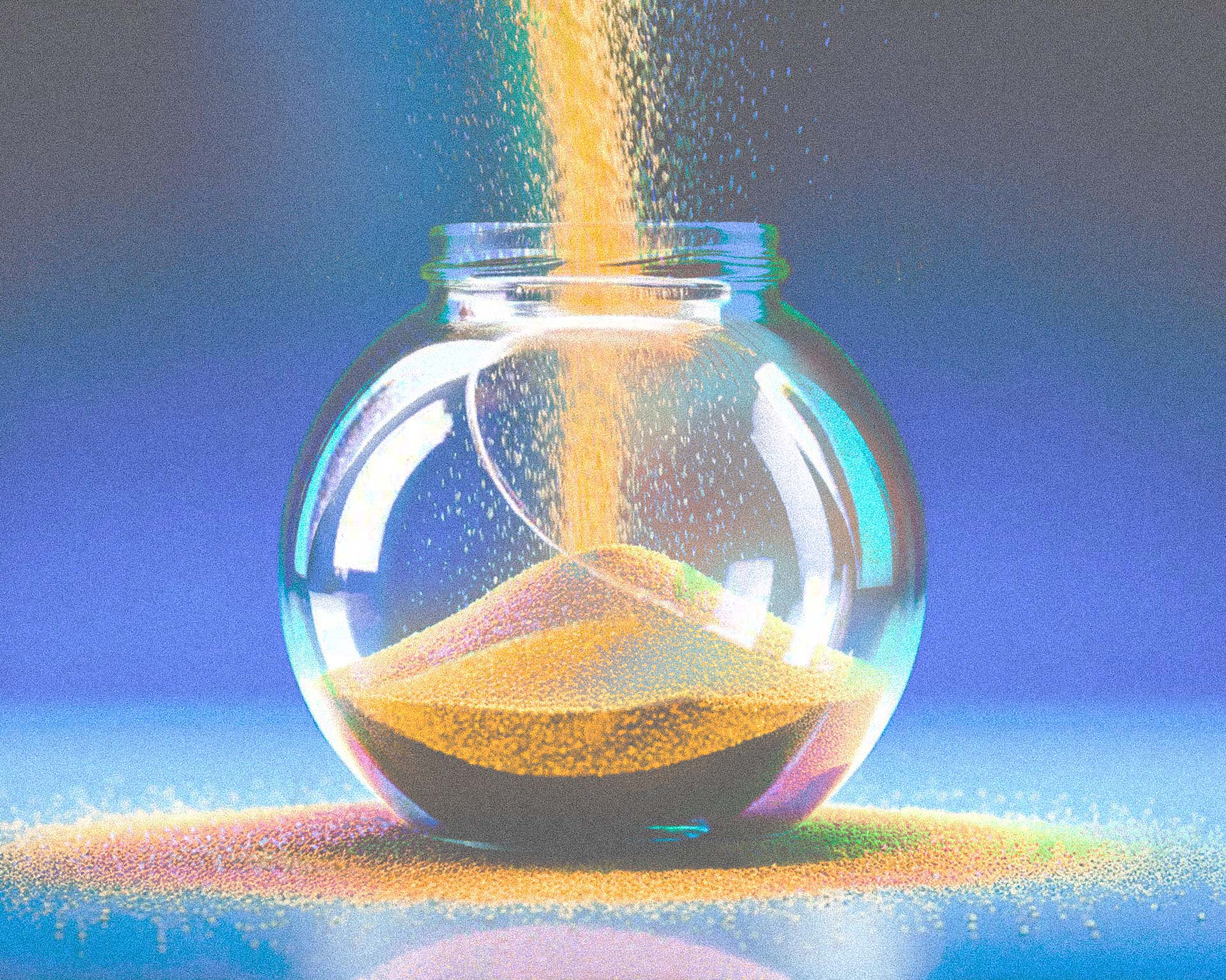Sulla necessità, o meno, di un Linguaggio Inclusivo.
Non ce lo siamo chiesto solo noi: Vera Gheno, ti abbiamo preso in prestito le parole, senza anticipare la tua risposta (che, se proprio ve lo state chiedendo, è no, la lingua non dovrebbe essere un Museo).
Ma procediamo per gradi: in che senso un Museo? Nel senso che ci si chiede sempre più spesso se un Linguaggio Inclusivo, che tenga conto della differenza dei generi e ne assicuri un trattamento e un riconoscimento paritario, si sia reso necessario. E se quindi la lingua debba evolversi insieme al tempo e alla cultura in cui è parlata.
Per rispondere (sempre che sia possibile fornire una risposta univoca), partiamo da una premessa: vale sicuramente la pena porsi la domanda. Alla faccia dei benalstristi, quelli che dicono che “eddai, i problemi sono ben altri”. Mmh, sì, valanghe di problemi sommergono il mondo, ma una domandina sul Linguaggio Inclusivo noi ce la siamo fatta – noi che del linguaggio vogliamo prenderci cura, noi che del linguaggio non vogliamo dare niente per scontato. E non lo facciamo solo noi. Per esempio, il World Economic Forum ogni anno stila un report per identificare le iniziative e le best practice che promuovono i DEI (Diversity, Equity and Inclusion) in aziende di tutti i settori. Per nulla di meno che “plasmare una economia globale inclusiva”. Il punto, allora, è che i DEI sono importanti in ottica valoriale, ma anche economica: “Amid economic volatility, organizations continue investing in DEI, fostering resilience and innovation for sustainable economic growth.”
Ma che cos’è, quindi, il Linguaggio Inclusivo?
Le Nazioni Unite lo definiscono come una serie di pratiche e strategie che mirano a usare un linguaggio non discriminatorio. Evitare espressioni stereotipate (meglio non dire, per esempio, “si veste come una femminuccia”). Distinguere i generi con i pronomi e i sostantivi corretti (senza essere pigri, o parchi di accortezze: a volte possiamo ben dire “gli studenti e le studentesse vanno al mare”, invece di ricorrere al maschile esteso). Prediligere – se si può – il genere neutro (un bel “chiunque” invece di “tutti” non fa male a nessuno). Che poi, la lingua italiana è particolarmente ostica, da questo punto di vista, perché le sue parole, anzi i suoi nomi, si distinguono in diversi tipi. Ci sono i nomi di genere comune che cambiano il maschile nel femminile grazie all’articolo (il giornalista / la giornalista). Ci sono i nomi di genere promiscuo, che hanno un’unica forma sia per il maschile che per il femminile (la tigre maschio / la tigre femmina). Infine, i nomi di genere mobile, che cambiano desinenza (maestro / maestra).
Qui si apre un mondo, soprattutto quello relativo all’uso del femminile nei nomi professionali, materia tra le più dibattute. Se sono una professionista legale, sono avvocato o avvocata? Se sono Lydia Tár, sono maestro o maestra d'orchestra? E l’esempio non viene a caso: il femminile di maestro rimanda immediatamente alla professione di insegnante elementare, e si potrebbe dire che sottenda uno svilimento del ruolo. (Lydia, sappiamo che tu non l’avresti mai permesso!) E se di mondi ne vogliamo aprire più di uno (già che ci siamo), non possiamo non citare l’ancor più dibattuto uso dell’asterisco o della schwa come desinenza per i plurali che comprendono persone di generi diversi (i cosiddetti gruppi misti) o persone non binarie. Ormai più che sdoganati all’interno dei social media e nel mondo dell’attivismo (dove sono nati), sono velocemente sbarcati anche nel panorama editoriale.
Disclaimer: lungi da noi proclamare da che parte stia la verità, ma qui un classico elenco di pros and cons non ce lo leva nessuno.
Da una parte l’asterisco e la schwa sono più inclusivi, e pure “corretti”, perché descrivono più fedelmente la realtà. Dall’altra, arriva a gran voce la critica della storpiatura della lingua, e soprattutto della sua leggibilità, a discapito di sintassi e ritmo.
Per esempio, a proposito del linguaggio giuridico, l’Accademia della Crusca non le ha mandate a dire. Se da una parte esorta all’uso largo e senza esitazioni dei nomi di cariche e professioni volte al femminile, dall’altro esclude il ricorso a “segni eterodossi”, perché la lingua è prima di tutto parlata e la scrittura le deve corrispondere il più possibile. E quindi? Il Linguaggio Inclusivo è o non è necessario? L’asterisco va o non va messo? Sono una avvocata o un avvocato? Tante domande, come al solito, e poche risposte. Poche, ma buone. E più che risposte, raccomandazioni, compromessi, accortezze.
Non cedendo alla tentazione di dire “la lingua è sempre stata così” (la lingua non è un Museo), e considerando sempre il contesto in cui si parla, insieme alle informazioni o alle risposte emotive che si vogliono trasmettere. Per esempio, se non si fosse trattato del linguaggio giuridico, l’Accademia della Crusca sarebbe stata così severa? Ci risiamo, un’altra domanda :) È un vizio, che non vogliamo perdere.
Se ne hai anche tu, scrivici a supernova@remidastudio.com